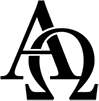L’evidenza dello spirituale nell’ascesi verso la Realtà-Verità
Docente di Fondamenti etici, filosofici e teologici presso l’Istituto Universitario Salesiano di Torino (IUSTO) – Università Pontificia Salesiana e di Bioetica presso l’Università Cattolica Sezione “Cottolengo” – Torino e Moncrivello (VC).. Tra le sue pubblicazioni: Coscienza e società. Lo spazio dell’obiezione di coscienza (Cittadella 2012); Il dovere dei diritti. Valore e valori della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (2018)
Introduzione
Due premesse. Laddove l’accento della mia riflessione si poserà sulle minacce che nel nostro tempo ottenebrano lo spirito, non sarà per disegnare scenari catastrofici, ma per avvertirci dell’importanza di salvaguardare lo spirito. Esso appartiene all’uomo, è ciò di cui siamo costituiti, o meglio ancora esso costituisce il fondamento stesso del nostro essere, la radice della nostra esistenza.
Seconda premessa. Paradossalmente, proprio attraverso le sfide contemporanee che coinvolgono lo spirito umano, si intravede la straordinaria grandezza della piccolezza dell’uomo. I dati concernenti le misure delle distanze che separano il nostro pianeta da altri corpi celesti risultano impressionanti. Si parla di distanze enormi che non possono lasciarci indifferenti. Un universo straordinariamente grande; un’eccedenza di energia e di materia che non ha confronti con la realtà del nostro quotidiano e, come se ciò non bastasse, questi dati riguardano il 4% della vastità dell’intero. Noi apparteniamo a quel 4% conosciuto, ma c’è un 96 % ancora da scoprire. Vastità spaziali e temporali che vanno ben oltre la nostra capacità di rappresentazione mentale.
Personalmente sono affascinato da questo “oltre”, che, ormai da diversi anni, guida la mia riflessione, anche in aree più specifiche di cui mi occupo per i miei insegnamenti. Sono sempre meno interessato alla casistica; o meglio ne sono interessato nella misura in cui essa ci riconduce ai nodi che sono alla radice delle molte questioni oggi dibattute. Nel tempo dei mutamenti repentini e della ricerca di soluzioni rapide, troppo spesso ci occupiamo dei fenomeni più manifesti e clamorosi. Su di essi concentra la nostra attenzione e la pressione dei mass media, rendendoli oggetto di dibattiti assai animati e di contrapposizioni ideologiche infinite. È urgente avere il coraggio di risalire alla radice delle questioni, per non continuare a girare intorno ai problemi e per trovare, probabilmente, anche possibili punti di convergenza.
Occorre tornare a occuparci della domanda sull’identità dell’uomo: “Chi sono?”, cosa rappresenta ciascuno di noi nel vasto e affascinante panorama dell’universo cui apparteniamo? Da queste domande fondamentali e inevitabili, si aprono riflessioni su riflessioni, troppo spesso eluse dalla filosofia contemporanea. Domande che sebbene estromesse dalla porta, rientrano comunque dalla finestra: sembra che oggi le sfide racchiuse in tali questioni siano affrontate da altre scienze, come l’astrofisica, che conducendoci ai confini di un oltre, il macrocosmo, riconduce necessariamente la nostra mente al microcosmo: “Chi sono io?”, “chi è l’uomo?” Il testimone della ricerca di risposte a questi interrogativi, finora affrontati dalla filosofia, è come se sia passato nelle mani di altri saperi. Saperi che occupandosi del proprio specifico oggetto di studio (“la realtà”) si trovano a doversi misurare con le domande esistenziali più profonde. Lo abbiamo sentito: l’astrofisica, mentre svolge la propria ricerca, si pone gli interrogativi del filosofo, ricercando le risposte nell’orizzonte sconfinato delle coordinate spaziali e temporali dell’universo. Un percorso affascinante. Ricerca l’origine del nostro universo e della vita, elaborando e perfezionando la teoria del big bang, e contemporaneamente affronta la domanda fondamentale da “dove vengo?”. E mentre analizza l’evoluzione dello stesso universo e della vita che lo abita, persegue l’altra domanda altrettanto fondamentale per l’uomo: “Verso dove vado?”.
Questi interrogativi ci appartengono, appartengono all’uomo. Di contro ho invece la sensazione che i giovani non siano più messi nelle condizioni di porsi queste domande fondamentali. Si riflette in loro il timore di noi adulti di affrontare tali questioni; di aver “tirato i remi in barca” rispetto alle domande ultime della vita e quindi di tacerle non sapendo altrimenti cosa dire. Ho fiducia che i colleghi che si occupano di materie scientifiche continuino, con i loro studi, a evidenziare un’area che altrimenti resterebbe in qualche modo inesplorata. Lo penso rassicurato da un altro contesto che frequento in occasione dei miei insegnamenti: quello degli operatori sanitari. Per un’interessante analogia, le domande con cui si misura l’uomo che indaga gli spazi e i corpi del macro-universo sono le stesse che si pone e solleva la persona malata. Le corsie ospedaliere si rivelano un ambiente drammaticamente sensibile a questi interrogativi, perché fra quelle pareti si trova l’uomo spogliato da ogni sovrastruttura. L’uomo che tocca il limite della malattia e della morte. Nelle camere d’ospedale si fa filosofia nel senso più ordinario del termine. Non una filosofia accademica ma, appunto, quella della quotidianità provocata dalla relazione con chi è costretto a porsi la domanda sullo stato e sulla condizione della propria vita.
1. Crisi: la parola d’ordine del nostro tempo
Se c’è una parola che caratterizza il nostro tempo, è la parola “crisi”. Tutto è in crisi: la famiglia, il lavoro, l’economia…e tutte queste crisi sono denunciate nella loro complessità. Viene però taciuta una crisi che probabilmente sta al centro di ogni altra crisi: quella “spirituale”. Quando mi è stato richiesto di riflettere e di scrivere sul rapporto tra l’etica e la spiritualità ed ha preso forma quel testo che porta il titolo Lo spirito dell’etica, si è rafforzata in me l’idea che l’una e l’altra convergano fino a coincidere[1]. Più rifletto, infatti, su questioni etiche, più mi convinco che la crisi dell’etica è in realtà segno di una crisi più radicale. La crisi dello “spirito”. Oggi più che mai viviamo una di crisi di significato e se il significato è in crisi non può non esserlo l’agire etico, che è l’agito del significato, di quanto, cioè, noi comprendiamo come significativo. Se non conosciamo il significato, il nostro agire sarà un agire in qualche modo vuoto, compensato dalle regole, le quali tuttavia non bastano, perché mentre ci avvertono delle condizioni che strutturano la convivenza, permettendone la realizzazione, non motivano. Non offrono cioè quelle motivazioni per cui anche in assenza di un controllo esterno si è motivati a rispettare la legge. Per dirla più semplicemente: mentre senza motivazioni il rispetto delle regole sarà affidato alla forza coercitiva dell’autorità, in presenza delle motivazioni, tale rispetto si radicherà nella forza della coscienza personale, per cui, anche in assenza di un controllo esterno, non verrà meno il senso delle proprie responsabilità personali. In questo senso “crisi dello spirito” (che è bene ricordare coincide con l’uomo stesso nelle dimensioni della sua libertà e della sua ragionevolezza, e non dello Spirito con la S maiuscola, che fortunatamente non è mai in crisi), “crisi spirituale contemporanea”, o meglio ancora “crisi della percezione e dell’apprezzamento della nostra dimensione spirituale”, esprimono la scarsa importanza che è attribuita allo spirito da parte del nostro contesto culturale in cui tale crisi si esprime e si manifesta.
A conferma di questa lettura basti considerare i titoli di alcuni testi scritti da pensatori contemporanei sul nostro tempo. Iniziamo da Galimberti con il suo scritto L’ospite inquietante[2]. Cos’è quest’ospite inquietante? Il nichilismo, il vuoto interiore. Benasayag e Schmit, il primo psicologo e l’altro filosofo, riferendosi alla condizione dei giovani scrivono “L’epoca delle passioni tristi”[3]. Tristi perché prive di sentimenti positivi, in primis privi della speranza verso il futuro. Fortunatamente Benasayag ha sviluppato le sue riflessioni producendo un testo nel quale prospetta un orizzonte “Oltre le passioni tristi” per il superamento dell’attuale situazione [4].
Insieme al nichilismo e alle passioni tristi che l’accompagnano c’è un altro termine caratterizzante il nostro tempo analizzato da un filosofo di origine coreana. Il termine è pregnante almeno quanto gli altri due, non fosse altro che per la frequenza con cui lo usiamo per definire il nostro stato di vita: “Stanchi”. Il filosofo a cui faccio riferimento è Byung-Chul Han il quale scrive “La società della stanchezza”[5]. Siamo sempre stanchi, ma non di una stanchezza fisica, della stanchezza psichica di avvertirci “perennemente sotto esame”, o perché effettivamente gli altri ci esaminano o, più frequentemente, perché noi stessi “ci poniamo sotto esame”. La radice di questa percezione sta nell’impronta assunta dalla nostra cultura in cui, più che la relazione, prevale la prestazione. Devo pertanto essere perennemente all’altezza della situazione, devo essere, uso l’espressione coniata da Byung-Chul Han, ininterrottamente “imprenditore di me stesso”. Un tratto, quello appunto di questa imprenditorialità individuale, tanto più acuto, quanto più avvertiamo di doverci comprendere come individui solitari. L’individualismo che caratterizza l’occidente ci sovraccarica di compiti e di aspettative assai maggiori rispetto ad altri momenti storici nei quali era diffuso un maggior senso di appartenenza e di condivisione. In quel contesto molti interrogativi esistenziali erano affrontati e sostenuti insieme. Avveniva qualcosa di simile a quello che accade nell’esperienza dei nostri gruppi di ricerca e di riflessione. Isole o oasi privilegiate in cui diamo ossigeno al nostro spirito, avvertendo quanto sia importante non essere soli nell’affrontare le questioni della vita e del mondo.
Stando così le cose, viene da chiederci cosa sia ritenuto importante nel nostro tempo. Esprimo la risposta considerando la questione dal punto di vista scientifico e da quello etico. Dal punto di vista scientifico ciò che resta è la tecnica; dal punto di vista etico rimangono le regole. La tecnica non è forse necessaria? Certo che lo è. E le regole non lo sono altrettanto? Anche in questo caso dobbiamo riconoscere che sono anch’esse necessarie. Tuttavia tecnica e regole sono insufficienti. Delle regole abbiamo già detto abbastanza. Quanto alla tecnica essa offre sicuramente strumenti utili quanto indispensabili ma, come sottolinea Galimberti, non si propone alcun fine da realizzare, solo risultati da raggiungere. La tecnica in se stessa non ha fini, poiché la sua funzione è strumentale. È ciò che ci permette di arrivare a un fine, ma se non conosciamo il fine o se non ci disponiamo alla ricerca del fine, la tecnica non può offrirci risposte.
Di fronte ad alcuni progetti tecnico-scientifici la domanda che sorge spontanea è il loro perché. Perché la progettazione di un post-umano?[6] Per dimostrare che cosa o per raggiungere che cosa? Se infatti non ci sono dubbi sulla bontà della tecnica quando questa è applicata a scopo terapeutico (si pensi alle protesi più semplici come gli occhiali, fino a quelle più complesse come il pacemaker o le protesi sostitutive di un arto…), sono molti gli interrogativi che sorgono quando l’uomo cerca di superare se stesso: perché forzare l’umano? Perché voler andare oltre il dato di realtà?
2. Un perché per vivere
In ultima istanza la questione di fondo è proprio quella del perché: “Perché vivo”, qual è il senso della mia esistenza, del mio vivere con altri esseri capaci di intelligenza e di libertà. La ricerca di una risposta a questa domanda non è un capriccio, ma un bisogno dell’uomo, un desiderio radicale e profondo, che appartiene all’essere umano. Potremmo parlare a questo proposito dell’umana capacità di pensare su se stesso, come di una vera e propria “evidenza scientifica”.
Lo stesso ‘900 è stato testimone di correnti di pensiero, che attestano l’esistenza di un senso che ci precede, che sta prima di noi. Una verità (aletheia in greco) che si disvela ri-velandosi e che pertanto ha la forma del mistero che affascina, attrae e genera il desiderio di conoscerlo. Sto pensando in particolare alla fenomenologia introdotta da Husserl, ma anche a correnti dell’esistenzialismo e dell’ermeneutica. Il senso non è dato nella forma dell’evidenza immediatamente manifesta, ma del disvelamento rivelativo, che attende di essere accolto e interpretato. Posizioni che ben si coniugano con i convincimenti dell’uomo credente.
Lo stesso ’900 contiene però posizioni che sostengono il contrario. Si pensi a Nietzsche, a Sartre, a Camus … Ciò che è particolarmente interessante dal punto di vista della nostra riflessione, è che tuttavia, anche questi indirizzi di pensiero, mentre negano l’esistenza di un senso, in contemporanea affermano, almeno in modo indiretto, che l’uomo non può farne a meno. Poiché “dio è morto” l’uomo è destinato all’arduo compito di dare un perché alla propria vita, di farsi creatore di un senso. Insomma, la risposta alla questione del senso è e resta per tutti la questione vitale. Essa rappresenta un momento fondante della nostra esperienza spirituale, l’esperienza dell’uomo inteso con Teilhard De Chardin, come “fenomeno cosciente”, che ha la sua prima assai significativa manifestazione nella sepoltura dei morti. In quel gesto, per noi ormai così scontato, è racchiusa una riflessione altissima dell’uomo sull’uomo. Più esattamente sul valore della sua esistenza apprezzata a tal punto da arrivare a ritenere che il suo corpo non possa essere abbandonato come un qualsiasi altro cadavere di altri esseri viventi. Un’importante testimonianza di acquisizione di coscienza e di autoconsapevolezza, ma anche di rielaborazione dell’evento della morte.
La psicologia ci conferma il bisogno esistenziale per l’uomo, di un perché per cui vivere. A questo proposito risulta pregnante il libro di Viktor Frankl nel quale, da psicologo, rielabora l’esperienza da lui stesso vissuta nel campo di concentramento[7]. La conclusione sintetica delle sue riflessioni si può riassumere in un’affermazione che condensa il suo scritto: “Chi ha un perché per vivere sopporta quasi ogni come”. A parte, ovviamente, coloro che erano uccisi, la capacità degli altri di sopportare gli stenti e gli sforzi fisici a cui erano costretti si rivelava correlata al fatto di avere un motivo per cui ritornare a casa. Un “motivo per cui vivere” è ciò di cui l’uomo non può fare a meno, pena la compromissione della sua stessa sopravvivenza.
Altrettanto interessante è quanto scrive Jung nella sua auto-biografia: “Sono incapace di stabilire un valore o un non valore definitivo, non ho un giudizio da dare su me stesso e sulla mia vita, non vi è nulla di cui mi senta veramente sicuro. Non ho convinzioni definitive proprio di nulla, so solo che sono venuto al mondo e che esisto e che mi sembra di esservi stato trasportato. Esisto sul fondamento di qualche cosa che non conosco ma, nonostante tutte le incertezze, sento una solidità alla base dell’esistenza e una continuità nel mio modo di essere. Il mondo nel quale siamo nati è brutale e crudele e nello stesso tempo è di una divina bellezza. Probabilmente la vita o ha significato o non ha significato. Io nutro - terminano queste considerazioni di Jung - l’ardente speranza che il significato possa prevalere e vincere la sua battaglia” [8]. La speranza che ci sia un significato, che la percezione della nostra vita poggiata su un fondamento, non sia un’illusione, che esista qualcosa capace di dargli davvero consistenza … è ciò che nutre la speranza dell’uomo.
Vanno nella stessa direzione i rilievi sociologici intorno all’attuale interesse per l’esperienza spirituale. Pensiamo al successo che ottengono manifestazioni e convegni che trattano di spiritualità. Intorno ad essi si concentra molta attenzione, che va sicuramente analizzata in modo critico, per evitare di raggiungere conclusioni ingenue, ma che ci conferma comunque che “non di solo pane vive l’uomo”. È come se la secolarizzazione non sia riuscita a estirpare dall’uomo quel moto dello spirito che gli procura interesse per il senso della propria vita. Un interesse che da sempre l’ha spinto e ancora lo spinge a riflettere su di sé, per scoprirsi soggetto in relazione con gli altri, senza i quali neppure sarebbe. Nel rientrare in sé stesso, è infatti offerta all’uomo la possibilità di scoprire di esistere nella relazione, che gli ha donato l’essere e che lo fa essere e che, in una prospettiva di fede, lo farà essere anche dopo la morte.
Tuttavia non è questo il solo possibile esito dell’attuale ricerca spirituale. Essa potrebbe trasformarsi in un soggettivismo intimistico e surreale. In particolare esiste oggi il rischio di un ennesimo marketing dello spirituale, nel quale ciascuno “prende ciò che più gli piace”, senza preoccuparsi della verità del dato di realtà; una sorta di nuovo olimpo nel quale c’è una divinità per tutto e per ciascuno.
È la scorciatoia contemporanea rispetto al compito di accettare il tempo della ricerca, è la riproposizione del peccato delle origini: tutto e subito, basta mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male, bello da vedere e buono da gustare, per diventare come dio. La conoscenza però non è immediatamente un frutto da mangiare, da consumare, è più simile a una semina che prepara il raccolto. Il contadino sa bene che non esiste un raccolto immediato, senza attesa, senza spendere se stessi in quella semina che un giorno diventerà raccolto.
3. Il coraggio della “consapevolezza”
L’apertura verso la ricerca di senso implica un processo di consapevolezza, o meglio ancora di auto-consapevolezza che ai nostri giorni non è certamente favorito. Il sistema consumistico-commerciale nel quale viviamo è un sistema per cui meno abbiamo consapevolezza, meglio è. Potremmo dire che sopravvive all’insegna dell’inconsapevolezza, se non addirittura alle spalle dell’inconsapevolezza. La mancanza di consapevolezza non coincide con l’ignoranza. Oggi le persone che vivono nel nostro continente, almeno la maggioranza, sono istruite e professionalmente preparate e competenti. Non è questa la mancanza cui ci riferiamo, ma all’attenzione e alla cura di quello spazio interiore nel quale emergono le domande esistenziali.
Un esempio fra i molti che potrebbero aiutarci a decifrare la portata esistenziale dell’acquisizione di consapevolezza è il senso di meraviglia che ci sorprende quando ci troviamo immersi nello spettacolo di un paesaggio della natura. Pensiamo alla meraviglia che si sperimenta di fronte ad una montagna che spicca per la sua maestosa e scultorea imponenza, a una distesa di acqua il cui colore si confonde con quello del cielo, a un giardino in fiore, a una stellata in una nitida serata d’estate, a ciò che possiamo immaginare si possa provare potendo disporre di un potente telescopio capace di estendere la nostra vista oltre i suoi confini naturali, verso l’universo… Ebbene in queste esperienze, la consapevolezza è ciò che ci permette di avvertire in quegli eventi il coinvolgimento del nostro io con i suoi sensi esterni e interni, di avvertire contemporaneamente la nostra piccolezza (il fascinoso ci appare come immensamente più grande di noi), ma anche la singolarità del nostro valore, manifestato nella capacità di provare meraviglia e stupore (qualcosa che non sarebbe senza di noi); di scavare nella ricerca della nostra identità fino a scoprirla, come direbbe Teilhard de Chardin, materia spirituale. Quando le esperienze vissute, come quelle sopracitate, vengono portate al piano della consapevolezza, avvertiamo infatti che il nostro corpo non è solo materia, ma “materia spirituale”. Materia che vibra nella sua intimità per l’eco in lei suscitato dalla presenza di ciò che la circonda e che gli si manifesta nella forma del bello, del bene e del vero. Al corpo appartiene un’interiorità spirituale che lo distingue da qualsiasi altro essere vivente.
Come se ciò non bastasse, l’interiorità del corpo umano non ripiega su se stessa, ma proietta l’uomo oltre i confini del proprio io. Lo ha espresso bene Agostino in un famoso testo delle sue Confessioni in cui rivolgendosi a Dio dichiara: “Tu eri dentro di me ed io ti cercavo fuori di me”. Lo spirituale che costituisce il nostro corpo, attesta la presenza dell’Altro dentro di me. Prenderne consapevolezza significa sentirsi proiettati fuori di sé. Accade un movimento apparentemente paradossale: rientro in me stesso, e quest’accesso dentro di me mi conduce fuori di me, verso l’altro da me, disponendoci ad accogliere un altro tema caro a Teilhard, quello della complessità e della relazionalità. Tutto è connesso in una complessità difficilmente districabile eppure reale, per cui mentre sperimentiamo stupore nel contemplare i micro-organismi (compreso quello della nostra individualità), come anche il macro-organismo dell’universo, questo medesimo stupore ci sorprende laddove scopriamo che tutto è connesso.
Non solo, nella nostra coscienza scopriamo che la conservazione della nostra relazionalità con il resto del mondo vivente, non è un fatto prettamente meccanico e automatico, ma coinvolge la presenza in noi della libertà e della sua forza. Uno tra i molti motivi di preoccupazione che sorgono dalla creazione dei cosiddetti cyborg (individui in cui l’umano è potenziato dall’inserimento nel corpo di strumentazioni tecnologiche, tanto da arrivare a parlare di trans-umanesimo se non di post-umanesimo), è che sia ridotta, se non cancellata, quella straordinaria realtà che è la libertà. Non stiamo parlando di fantascienza, dal momento che sembra imminente la possibilità di installare uno o più microchip che interfaccino il nostro cervello con un computer. Questo permetterà certamente di ampliare l’archivio della nostra memoria, ma a quale prezzo? Quali messaggi e informazioni saranno immessi nella nostra mente? E ancora più radicalmente, chi sarà il regista di tutto questo? In quell’ibrido, creato dalle nostre manipolazioni, sarà salvaguardata quella dimensione specifica dell’identità umana, che è la libertà?
Non è questo il luogo in cui affrontare le questioni sollevate dalla tecno-scienza. Il farne menzione in questo contesto è finalizzato unicamente a evidenziare la portata e l’importanza delle nostre scelte. Scelte riconducibili all’esperienza spirituale dell’uomo cui, di fatto, appartengono. Quella dell’uomo è infatti una spiritualità etica: una spiritualità che l’uomo vive nella libertà, le cui scelte incidono, oltre che su sé stessi, sul presente e sul futuro dell’umanità e dell’intero nostro Pianeta. L’uomo si trova permanentemente di fronte ad un bivio contrassegnato da un interrogativo esistenziale di sintesi che interpella la nostra libertà: ritieni la vita affidabile o non affidabile? Da parte sua la vita si propone come istanza interpellante, che ripresenta continuamente il suo invito: “Affidati”, “fidati”, vivi la tua esistenza secondo la logica dell’affidamento, quale chiave di lettura dell’esistente. Essa ti metterà nelle condizioni di conoscere la realtà, di comprenderla e di apprezzarla, fino a scoprirne la sensatezza. È di fronte a questa interpellanza che ogni essere umano è chiamato a prendere posizione. La libertà è provocata ad accettare la credibilità della promessa inscritta nella vita, pur consapevole che potrebbe anche rifiutarla.
Questa istanza di affidamento alla vita si coniuga con il coraggio di assumere in piena consapevolezza quell’intenzionalità che attraversa e accomuna ogni uomo. Ci riferiamo a quell’intenzionalità che “suggerisce” all’io di tutti noi, l’impegno all’umanizzazione della nostra esistenza: “Vivi la pienezza della tua umanità secondo la tua umanità e quella di chi ti sta accanto e interpretala nel rispetto dell’ambiente che ti circonda e a cui tu stesso appartieni”. E ancora: “Abbi il coraggio di spendere la tua esistenza con lo sguardo di chi ha la consapevolezza che la propria vita è connessa, anzi interconnessa ad altre vite. Quelle che ti hanno preceduto, quelle che vivono il tuo tempo e quelle che verranno dopo di te”.
In sintesi possiamo affermare che il nodo etico fondamentale si racchiude in questa duplice opzione: fidarci del lato promettente della vita e spenderla nella ricerca della sua umanizzazione. Solo dalla risoluzione di questa duplice istanza potremo disquisire sulle singole questioni tematiche, definire le azioni buone distinguendole da quelle cattive, racchiudere quanto compreso e apprezzato in un codice normativo di comportamento… Tra le possibili soluzioni che potranno essere adottate di fronte alle specifiche problematiche morali, quelle che saranno scelte dipenderanno infatti dalla percezione che si ha della vita e del suo senso.
Non è un caso che l’attuale tempo di crisi sia caratterizzato da una diffusa mancanza di fiducia di base sia nella forma di una scarsa fiducia reciproca, sia di una profonda sfiducia verso il futuro. Senza affidamento sensato la vita s’impoverisce fino a perdere significato.
4. La spiritualità della ricerca scientifica
Le considerazioni sin qui svolte rendono impossibile individuare una linea di separazione tra lo spirituale e l’etico. La libertà interpellata dalla “Vita” ha il grande compito di accoglierla e, all’interno di un tale contesto di accoglienza, di compiere le singole scelte più puntuali. Proprio quest’unità dello spirituale-etico ci permette di raggiungere uno dei tratti caratterizzanti la ricerca scientifica, sebbene spesso trascurato. Essa, nell’onestà dei ricercatori e nella loro correttezza metodologica e procedurale, ha una sorta di componente spirituale, che può raggiungere le vette della mistica. Chi fa ricerca è infatti simile a un asceta che ha una verità da scoprire, senza però poter dare per scontato di raggiungerla e tantomeno di possederla definitivamente (è questo ciò che potremmo definire come il versante “mistico” della ricerca); inoltre ha una disciplina da seguire: la ricerca stessa è disciplina e disciplinato ne è anche il percorso metodologico, non ultima vi è la disciplina della comunicazione. Si tratta della condivisione con i propri colleghi dei risultati raggiunti. Un momento nel quale il ricercatore assume la consapevolezza che il risultato da lui conseguito non è una proprietà privata; che la comunicazione deve attenersi ai dati di realtà raggiunti; che non è producente seguire la tentazione del solipsismo; che per quanto bisogna considerare l’aspetto economico, non è opportuno sottostare al suo ricatto, che vorrebbe risultati strepitosi in tempi ristretti pur di soddisfare il mercato[9]. La spiritualità etica della scienza impone esattamente il contrario, esigendo tempo e spazio per la ricerca, richiedendo investimento di energie, comprese quelle assorbite dalla frustrazione del fallimento. La constatazione che non sia quella la strada da percorrere, è infatti comunque significativa dal momento che permette a sé e agli altri ricercatori di cambiare rotta.
Lo spirito della ricerca scientifica sin qui descritto accomuna ogni ricercatore “serio”, qualunque sia la sua connotazione “credente o non credente”. L’aggettivo “serio” sta proprio a esplicitare questo tratto trasversale tipico dell’uomo che fa della propria vita un tempo di ricerca.
Conclusioni in divenire
Jaspers scriveva che “la scienza sperimentale non è in grado di conoscere ed avvertire l’aspetto qualitativo della realtà”[10]. Affermazione legittima nel contesto positivista in cui egli rifletteva. Oggi dovremmo però auspicarci che “la scienza sperimentale si disponga a riconoscere l’aspetto qualitativo della realtà” pena il suo risultare sterile, se non persino dannosa.
Questo pensiero tradotto in termini di spiritualità-etica si declina in tre principi di riferimento: responsabilità, precauzionalità e giustizia. Una scienza che voglia essere etica non può che seguire il principio di responsabilità, nel senso di responsare, farsi risposta di fronte all’alterità accogliendone la presenza.
Precauzionalità, riconoscendo che non tutto quello che è tecnicamente possibile è eticamente sostenibile. Il livello di possibilità raggiunto dall’attuale ricerca tecnico-scientifica, si pensi all’ingegneria-genetica, è tale da non rendere del tutto prevedibili e controllabili gli esiti delle varie applicazioni. Il principio di precauzione invita alla prudenza per evitare di raggiungere risultati indesiderati.
Ultimo, ma non ultimo, il principio di giustizia. Tutti dovrebbero poter godere dei benefici generati dai progressi della scienza e della tecnica.
Potremmo rappresentare la via tracciata da questi principi, come una strada a tre corsie, tutte necessarie per raggiungere la meta: crescere nell’ascesi verso la Realtà-Verità.
Articolo apparso su Teilhard aujourd'hui 27 (giugno 2018)
[1] Paolo Mirabella, Lo spirito dell’etica. Agire nell'epoca della secolarizzazione, Cittadella, Assisi 2016.
[2] Umberto Galimberti, L'ospite inquietante, Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007.
[3] Miguel Benasayag – Gérard Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2003.
[4] Miguel Benasayag, Oltre le passioni tristi. Dalla solitudine contemporanea alla creazione condivisa, Feltrinelli, Milano 2016.
[5] Byung-Chul Han, La società della stanchezza, Nottetempo, Roma 2012.
[6] Molto interessante a questo proposito la trasmissione di Report andata in onda il 2 aprile 2018 su Essere umani in cui, accanto all’analisi di progressi tecnologici a servizio della salute umana, sono stati presentai progetti di potenziamento dell’umano fino a stravolgerne l’essere: il cyborg.
[7] Viktor Frankl, Uno psicologo nei lager, Ares, Milano 2007.
[8] Carl Gustav Jung, Ricordi, sogni, riflessioni, Raccolti e editi da Aniela Jaffè, Rizzoli, Milano 2002.
[9] Sappiamo bene quanto siano importanti le risorse economiche e quanto esse siano legate ai risultati raggiunti. Una pressione notevole sui ricercatori, ai quali viene sottratto il tempo necessario per produrre risultati significativi e comprovati, pena il rischio di chiusura del proprio centro di ricerca.
[10] Karl Jaspers, Il medico nell'età della tecnica, Raffaello Cortina, Milano 1991 (orig. ted. 1986).