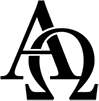La preghiera come luogo di divino-umanazione
Monaco benedettino dal 1983. Dopo i primi anni di formazione monastica ha conseguito il Dottorato in Teologia Spirituale presso l’Università Gregoriana di Roma. Nel suo servizio di intelligenza della fede e di accoglienza della vita, cerca di coniugare la sua esperienza monastica con l’ascolto delle tematiche che turbano e appassionano il cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo.
Per parlare della preghiera, non posso non evocare il mio essermi sentito chiamato a fare della preghiera il luogo non solo più importante, ma pure più caro della mia vita. Una breve nota biografica è necessaria non tanto per parlare di me, ma perché quanto vi dirò abbia meno il sapore dell’insegnamento e più il profumo della testimonianza. Diventare monaco e fare una scelta preferenziale per la preghiera sono stati per me la stessa cosa.
Il mio percorso vocazionale è cominciato come un orientamento verso la vita missionaria di annuncio del Vangelo tra i più poveri. Sono entrato nel seminario dei missionari comboniani in quarta ginnasio per dare come orizzonte alla mia vita quello dell’evangelizzazione nella forma di una solidarietà radicela con i poveri. Nel tempo di seminario tra i comboniani cui devo molto per quella che mi piace definire la mia evangelizzazione, ho scoperto di essere fatto per la preghiera e il silenzio, nel quadro di una vita ritirata e ben ritmata come avviene in monastero. La preghiera, che è una parte importante della vita di ogni uomo e di ogni donna, diventa la parte dominante nella vita di un monaco: non perché il monaco preghi e gli altri no, questa è la differenza, ma perché nella vita del monaco la preghiera non è semplicemente un elemento di aiuto alla vita, ma è un elemento fondante della vita.
Ciò che mi ha permesso di rimanere quarant’anni in monastero in cui sono entrato giovanissimo,, è proprio l’amore della preghiera, che si è trasformato, gradualmente, nella percezione della preghiera come luogo di crescita nella verità e di incremento di umanità. La preghiera è una realtà qualificante della nostra bontà e come tutte le cose qualificanti, ha bisogno di luoghi e tempi di qualificazione. La preghiera è un elemento qualificante per la nostra dimensione di umanità. Siamo diventati più umani differenziandoci dagli altri animali, con cui condividiamo il novanta per cento della nostra dimensione vitale, proprio quando ci siamo aperti alla trascendenza. A un certo punto della nostra evoluzione non ci siamo accontentati di passare dall’animalità all’ominizzazione come salto di specie a livello delle abilità tecniche, ma ci siamo aperti alla fase dell’umanizzazione. Per passare dall’ominizzazione all’umanizzazione l’elemento differenziante è la percezione e la coltivazione della trascendenza. Un “salto” che rimane sempre tutto da fare!
L’atto della preghiera, il primo atto di preghiera forse è stato collegato all’evento della morte di una persona cara che ci ha costretti a prendere coscienza della nostra mortalità e, al contempo, della nostra dimensione di eternità. I primi luoghi archeologici che attestano l’insorgere della civiltà umana sono le tombe per quanto primitive e i luoghi di culto per quanto rudimentali. La prima esperienza di differenza con gli altri animali è stata quella vissuta in occasione della morte di un nostro simile e, invece, di andare avanti come se niente fosse, abbiamo offerto un “servizio” di cura e di attenzione assolutamente gratuito e in pura perdita come è seppellire un morto, che non può neppure ringraziare e meno ancora ricompensare. Gli altri animali non lo fanno anzi o abbandonano le carogne dei loro simili alla natura e agli altri animali, oppure prima di morire ci si separa dal branco per morire in modo nascosto. La morte assume un senso solo a partire da un sentimento di trascendenza.
Siamo diventati umani, secondo questo processo, che va dall’animalità verso l’ominizzazione, per passare all’umanizzazione, proprio nell’atto di fermarci davanti alla debolezza estrema - quella della morte! – con un atto che possiamo definire di preghiera. Anche la persona più pratica o meno religiosa, davanti alla morte di una persona cara o stimata prende la parola e compie gesti che sono comunque oranti. Di conseguenza ogni volta, e oggi siamo un po’ in questo pericolo, che una società comincia a relativizzare il culto dei morti, è in pericolo di inciviltà con il rischio della barbarie. La ritualità è nata con i funerali e poi si è sviluppata nei culti dai più semplici ai più sontuosi come quelli dell’antico Egitto e dei Maya dall’altra parte del mondo. Come diceva lo psicanalista svizzero Carl Gustav Jung: “Le religioni sono un complesso sistema di preparazione alla morte”. Non esiste religione senza un pensiero sulla morte. La verità appunto è che il pensiero della morte ha generato negli esseri umani il desiderio di creare un senso, una continuità, un baluardo contro l’assurdità del vivere quando si scontra con lo scandalo esistenziale del morire.
Dopo essere nati come “animali-animati”, rinasciamo come esseri rituali. Secondo uno studio di qualche anno fa, delicato e complesso, ci sono dei gruppi di scimmie che mostrano di avere un indizio di vita cultuale. A quanto pare delle famiglie particolari di scimmie privilegiano dei luoghi in cui portano delle cose, che poi lasciano lì e che vanno a riprendersi per obbedire, appunto, a quella che sembra una embrionale attitudine cultuale. Ogni inizio e indizio di culto segna il passaggio dalla ominizzazione all’umanizzazione. Naturalmente, e questo ci piace di meno, vi è sempre il rischio di una possibile regressione di umanizzazione, il cui indizio è una perdita del senso della trascendenza, che si manifesta nel culto come ambito di una preghiera possibile. Per riprendere la suggestiva definizione di Jung possiamo dire che il culto è un baluardo alla paura della morte e un aiuto ad attraversare le inevitabili morti della vita.
Siamo diventati creature capaci di spiritualità nel momento in cui abbiamo saputo erigere un cippo in memoria di un morto oppure, come nel caso di Giacobbe a Betel, abbiamo eretto una pietra come segno di una esperienza di Dio dopo il sogno di una scala che mette in comunicazione il cielo e la terra: “Certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. […] Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo” (Gen. 28, 16-17).
Perché dico questo con una certa forza: perché secondo me troppo spesso, specialmente in ambienti intellettualmente elevati, si rischia di confondere la consapevolezza con una sorta di senso di superiorità nei confronti degli aspetti cultuali. In realtà è il culto che, almeno a livello evolutivo, ha aperto alla nostra umanità la porta del senso della trascendenza e, di conseguenza, della spiritualità. Ogni atteggiamento religioso, come quello appunto vissuto da Giacobbe, nel suo viaggio, nasce da uno spavento o da uno stupore come apertura ad altro e all’Altro!
Persino nei testi della Resurrezione del Signore Gesù troviamo stupore e spavento. Infatti le guardie rimangono tramortite, le donne, secondo Marco nel suo Vangelo, hanno talmente paura che dicono niente a nessuno, di ciò che è avvenuto davanti alla tomba di Gesù Crocifisso. L’uomo si sente impaurito, quando si trova davanti a qualcosa di più grande e che sfugge alla comprensione e al controllo. Questo panico può essere motivo di disperazione, oppure fondamento di una speranza non solo più grande, ma persino infinita. Paradossalmente la percezione spaventevole della propria finitudine apre alla gioia radiosa dell’infinito. La preghiera, ben aldilà delle sue forme, è il luogo di questa esperienza ineludibile per la nostra umanizzazione. L’apertura alla trascendenza ci porta oltre un funzionamento della vita automatico e ripetitivo: in una parola animale!
L’evoluzione della coscienza è tanto più umanizzante, quanto più apre alla trascendenza, il cui primo passo è lo stupore! Il senso della trascendenza è ben più grande di ogni sistema dogmatico-rituale, nondimeno ha sempre bisogno di un “dogma” come recinto entro il quale scavare il pozzo della spiritualità. Persino l’Eucaristia, in quanto sacramento “fons et culmen” della nostra esperienza orante della fede pasquale, se non genera una apertura alla trascendenza come energia di trasformazione del mondo, rimane semplicemente allo stato primario o primitivo e non è mai al riparo dal rischio di rimanere semplicemente un “memento mori”, un qualcosa che ci tiene al riparo dall’angoscia e dalla paura.
La preghiera del cuore, o, per intenderci, la preghiera interiore non va percepita in contrasto o in concorrenza con il culto. Il culto è una preghiera interiore in forma “esternata” e condivisa, frutto dell’interiorità e germe di interiorità. Questo vale per la celebrazione dell’Eucarestia durante la quale ognuno sa cosa fare e cosa dire, tanto da essere un’esperienza di trascendenza non solo esternata, ma anche condivisa, con una valenza sociale e comunitaria importanti.
La preghiera del cuore o preghiera interiore, è quella preghiera che in certo modo tocca l’elemento fondamentale della trascendenza, attraverso la quale sentiamo di non avere solo paura della morte, ma anche una gran voglia di vivere e non solo di sopravvivere. Se, per riprendere Jung, le religioni sono “un complesso sistema di preparazione alla morte”, il sentimento di trascendenza è un modo semplice di percepire la vita come un dono da vivere pienamente e sempre più pienamente. La parola del Signore Gesù Pastore buono e bello suona come una promessa: “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10, 10). A differenza degli animali e degli altri esseri senzienti, come umani non ci basta lasciare qualcuno e qualcosa dopo di noi – come il seme per la pianta e un piccolo per l’animale – per sentirci al sicuro dal terrore di scomparire. Come umani sentiamo il bisogno e il desiderio di una eternità, che ci appartiene e questa non va confusa assolutamente con l’immortalità. In natura le cose si risolvono con la sopravvivenza della specie, in cultura viviamo il dramma del desiderio di una vita piena. La preghiera è il luogo in cui sentiamo di poter contestualizzare la nostra vita temporale, mortale e limitata, nell’infinito e nell’eternità.
Il “memento mori” che sta alla base dell’atteggiamento religioso, diventa il “memento vivi” che sta al cuore del nostro sentimento di trascendenza. Allora mentre assistiamo all’indebolimento delle forze animali in noi, possiamo percepire o dovremmo percepire l’insorgere sempre più chiaro degli elementi di eternità dentro di noi con un desiderio emergente di ricongiungimento.
La preghiera cultuale è un simbolo di appartenenza sociale-spirituale. Quando celebriamo l’Eucaristia ascoltiamo gli stessi testi, ripetiamo le stesse parole e compiamo i medesimi gesti da una parte all’altra del mondo e con fusi orari diversi, con un senso di appartenenza radicale ad un corpo orante, credente, sperante e amante. Questo però, non è sufficiente per colmare il desiderio di trascendenza, che seppur passa attraverso il rito e il dogma non si riduce né all’uno né all’altro.
Nel migliore dei casi apre a quell’esperienza interiore di contatto intimo con il “germe divino” (1Gv 3, 9), che abita nel profondo del più profondo di ogni uomo e donna. Il senso di appartenenza e di “corpo condiviso” assicurato dal culto, si completa con la preghiera interiore che, oltre al senso di appartenenza, ci permette di sentire un’identità unica e per certi aspetti così intima da non essere condivisibile. Etty Hillesum paragona le questioni della preghiera con “le faccende sessuali” che sono, appunto, intime e segrete.
Il contesto del mondo in cui viviamo, che per molte ragioni viene definito individualista, in realtà è il mondo più bello che ci sia mai stato. Questo perché, nonostante tutte le complessità e la ambiguità, abbiamo maturato, sulla spinta del Vangelo, un desiderio di libertà per tutti gli uomini e le donne del pianeta. Che poi non ci si riesca concretamente è un altro discorso! In ogni modo nel nostro tempo e nel nostro mondo la libertà, che è l’essenza dell’annuncio in Cristo della volontà di Dio per tutti i suoi figli e le sue figlie, è un valore ormai condiviso almeno nel desiderio.
Sfido chiunque ad aprire un libro di storia e indicare un tempo “migliore” di quello che ci è dato di vivere, per quanto riguarda, appunto, non la religiosità, ma l’umanità. Nonostante tutti i nostri limiti, le nostre infedeltà, i nostri paradossi e le nostre ambiguità, dal punto di vista di una coscienza condivisa, desideriamo che ogni uomo, ogni donna, almeno lo desideriamo, lo diciamo, possa essere all’altezza della propria vocazione di umanità in una dignità riconosciuta e condivisa in cammino verso quel punto Omega, di cui parlava meravigliosamente Teilhard de Chardin.
Questo incremento di intelligenza del Vangelo, di cui la celebrazione del Concilio Vaticano II è stato ineludibile evento di grazia, è il frutto della presa di coscienza del fallimento della Christianitas durante la tristissima pagina della Shoah nel secolo scorso e immediatamente prima dell’indizione del Concilio Vaticano II da parte di papa Giovanni XXIII. La Shoah, infatti, si è consumata al cuore della Christianitas e, talora, in nome di una confusione gravissima tra cultura e fede, tra razza e religione. La vergogna per quanto è avvenuto nei campi di sterminio nazisti in Polonia e altri Paesi “cristiani” ha creato un sussulto di consapevolezza delle esigenze del Vangelo e un desiderio di fedeltà rinnovato e convertito.
Frutti di questo passaggio, amarissimo momento della nostra storia, sono stati la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e la conversione interna della Chiesa con la riflessione e le decisioni prese dal Concilio: ogni uomo e ogni donna è un mistero da rispettare e onorare come espressione della trascendenza divina, cui si deve adorazione “in spirito e verità” (Gv 4, 23).
Reduce dal servizio nella diplomazia vaticana tra Sòfia, Istanbul e Parigi, Angelo Giuseppe Roncalli, quando diventa Vescovo di Roma, sente il bisogno impellente di rispondere alla storia facendosi carico dei propri errori, piuttosto che di condannare quelli degli altri: il Concilio, pur confermando l’aspetto dogmatico-rituale, si apre ad una comprensione del mistero di Dio e del mistero dell’uomo come sua emanazione ed espressione.
Con la Gaudium et Spes, per la prima volta, la Chiesa ha riconosciuto l’inviolabilità del “sacrario della coscienza” di ogni uomo e donna, in realtà rinunciando al controllo e alla manipolazione della coscienza attraverso la religione, per imparare a stupirsi delle epifanie del Mistero di Dio nella vita e nelle vicissitudini di ogni uomo e di ogni donna, nella concretezza dell’esistenza con le sue gioie e fatiche.
La preghiera è il luogo privilegiato, in cui la vita divina si riversa nei cuori. Questa preghiera interiore non è ammazzata dal rito, ma è nutrita dai gesti e dalle parole rituali della preghiera condivisa. Talora rischiamo di pensare di essere nati “spirituali” e di esserci, per così dire, abbassati ad essere “rituali”. In realtà è la ritualità come espressione dell’evolversi della nostra umanità, differenziatasi dall’animalità condivisa con gli altri esseri viventi, che ci ha aperto la possibilità di una coscienza sempre più ampia e profonda.
Ecco perché siamo chiamati a continuare e a praticare i nostri riti con modestia. In una parola la ritualità lancia processi di coscienza della trascendenza il cui esito rimane aperto e le cui forme sono infinite quanti sono i cuori degli uomini e delle donne. Il rito, dunque, non è un impedimento alla preghiera, ma una soglia per la preghiera come accesso alla trascendenza. L’elemento religioso può essere un impedimento alla trascendenza, solo se si accascia nell’ossessione rituale, che placa la paura della morte. La “re-ligio” significa rilegare e rileggere al contempo. Per questo il suo essere trappola o opportunità, dipende dal nostro modo di viverlo come mummificazione dell’anelito di trascendenza in forme ripetute e ripetitive, o come soglia per andare oltre… sempre oltre fino ad inabissarsi nel mistero.
Bisogna vigilare sul rischio di esentarsi dalla ritualità in nome della spiritualità, per il pericolo di confondere la propria esperienza con la totalità del mistero, che rimane non solo eccedente, ma che ha bisogno di “mezzi” espressivi e comunicativi. Il rito permette di non assolutizzare se stessi, per rimanere sensibili all’Altro. Paradossalmente il rito ci mette al riparo dal rischio di un’assolutizzazione di noi stessi, per tenerci piuttosto “legati” alla vastità del Mistero di cui siamo parte e mai centro.
Il Signore Gesù non si è sottratto alla ritualità, ma l’ha vissuta come soglia del Mistero e come mezzo del suo ministero di guarigione e di salvezza. Il Signore Gesù amava sostare (Lc 2, 41-50) e passeggiare (Gv 8, 2) nel Tempio. Proprio la sua fedeltà rituale e cultuale è il luogo interiore di una purificazione e di un approfondimento del senso della preghiera (Gv 2, 13-22). Senza nessuna remora il Signore risponde alla donna samaritana con forza: “!perché la salvezza viene dai Giudei”, subito dopo aver detto che “viene l’ora in cui né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre” (Gv 4, 21-22). Potremmo dire che l’incarnazione del Verbo nella persona di Gesù di Nazareth comporta la sua “ritualizzazione”. Se questo lo ha vissuto il Verbo di Dio, non possiamo certo non viverlo noi!
Il fatto che Gesù sia uomo “certior et verior” come afferma Tertulliano, comporta che sia un uomo di culto, perché la ritualità è un elemento della nostra umanità, senza il quale c’ è il rischio di una regressione animale. I nostri giovani, che non vengono in chiesa, hanno comunque i loro riti, i loro stregoni, i loro sacerdoti, che sono gli “influencer”. Infatti, non si può vivere senza una ritualità condivisa per sentirsi almeno minimamente “animali sociali”, secondo quanto afferma Aristotele.
Nel discorso della montagna, il Signore Gesù raccomanda ai discepoli di pregare non come i farisei per dare spettacolo di se stessi: “Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto” (Mt 6, 6. Si tratta di un invito alla preghiera interiore e non ad una preghiera “intimista”. Infatti, subito dopo aggiunge: “Voi dunque pregate così: “Padre nostro…” (Mt 6, 9). L’autenticità della preghiera interiore è che sia una preghiera radicalmente condivisa e solidale. Nel Vangelo di Luca, la consegna della “preghiera del Signore”, non fa parte dell’insegnamento di Gesù come in Matteo, ma la risposta alla domanda di un discepolo: “Signore insegnaci a pregare” (Lc 11, 1). Il contesto è ben precisato dall’evangelista: “Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse…”.
Il Signore Gesù coltiva la preghiera interiore, intima, ma non si nasconde nel momento della preghiera. La preghiera fa parte di quelle realtà intime che Gesù condivide serenamente con i suoi discepoli. Il Signore Gesù è fedele alla preghiera cultuale partecipando alle feste liturgiche, ma coltiva quella che oggi indicheremmo come “preghiera personale”. Una preghiera che è un segno distintivo del nostro essere creati a “immagine e somiglianza” di Dio. Il termine ebraico, che indica il servizio cultuale dei sacerdoti nel tempio – avad – è lo stesso che viene usato nella Genesi per indicare l’atto di affidamento della creazione all’umanità da parte del Creatore: “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2, 15).
Nondimeno il culto e la preghiera non hanno mai la precedenza sull’attenzione alla sofferenza concreta delle persone concrete, che il Signore incontra sul suo cammino. Gli esempi sarebbero tanti, ma ci basti evocare la parabola del “buon samaritano” (Lc 10, 29-37). L’intimo rapporto interiore con il Padre, rende il Signore Gesù straordinariamente sensibile e attento alla relazione con le persone e in particolare a quelle che soffrono.
Se è vero che il Signore Gesù è entrato in conflitto con il Tempio, per la sua capacità di non assolutizzare il culto, al contempo non ha mai relativizzato il culto. Non c’è opposizione tra rito e trascendenza, se queste due realtà sono espressione della ricerca di una relazione a livello verticale – con Dio – e orizzontale con tutti i fratelli e sorelle in umanità. La preghiera, in tutte le sue forme, prima di essere una “questione religiosa”, è una questione di “umanità”. La preghiera non serve a Dio, ma serve a noi, per assicurarci la possibilità di vivere quello scatto di consapevolezza, che ci rende suoi figli.
Ciò che uccide la verità e la bellezza della preghiera, è il suo mancato collegamento con la vita propria e quella degli altri, perché la preghiera è sempre una qualificazione e riqualificazione della nostra vita in umanità a motivo del suo radicamento nella vita divina. Per questo anche la preghiera più semplice e quella più segreta ha un impatto, per così dire, cosmico. Da questo punto di vista l’esperienza di Etty Hillesum – La ragazza che non sapeva inginocchiarsi – ma che un giorno, in bagno, comincia a pregare, può essere un esempio per i nostri giovani, che fanno tanta fatica a seguire il culto. Parlando della preghiera, Etty Hillesum la definisce un’esperienza più intima delle “faccende sessuali”.
La preghiera è una faccenda più intima della stessa energia sessuale, intima, più del sesso, più intima delle pulsioni sessuali, ciò detto mai intimistica, ma capace di sprigionare energie di compassione, di solidarietà, di intelligenza… in una parola: di umanità! La stessa Etty Hillesum testimonia che non ci può essere una vita di preghiera profonda, senza un impegno ascetico nel ritagliarsi tempi di preghiera e modi adeguati alla preghiera, come la sua mezz’ora mattutina vissuta in parallelo alla mezz’ora di ginnastica. Solo così la preghiera diventa quel “fagottino” inseparabile con cui affrontiamo la vita di ogni giorno, trasformando la nostra vita e quella degli altri. Pur non diventando mai cristiana, come al contrario fece Edith Stein, la vita di Etty Hillesum, proprio attraverso la preghiera, è diventata cristologicamente ed evangelicamente compatibile. Segno di questa compatibilità e l’estrema compassione con cui vive il suo ultimo tratto di vita nel campo di Westerbock.
La preghiera – cultuale e personale – è vita fino a cambiare la vita e renderla comunque “bella”! Possiamo concludere questa riflessione dando la parola a Etty Hillesum:
“Ieri sera, subito prima di andare a letto, mi sono trovata improvvisamente in ginocchio nel mezzo di questa grande stanza, tra le sedie di acciaio sulla stuoia chiara. Un gesto spontaneo: spinta a terra da qualcosa che era più forte di me. Tempo fa mi ero detta: mi esercito nell’inginocchiarmi. Esitavo ancora troppo davanti a questo gesto che è così intimo come i gesti dell’amore, di cui pure non si può parlare se non si è poeti”[1].
Testo pubblicato su Teilhard aujourd'hui 40 (ottobre 2022)